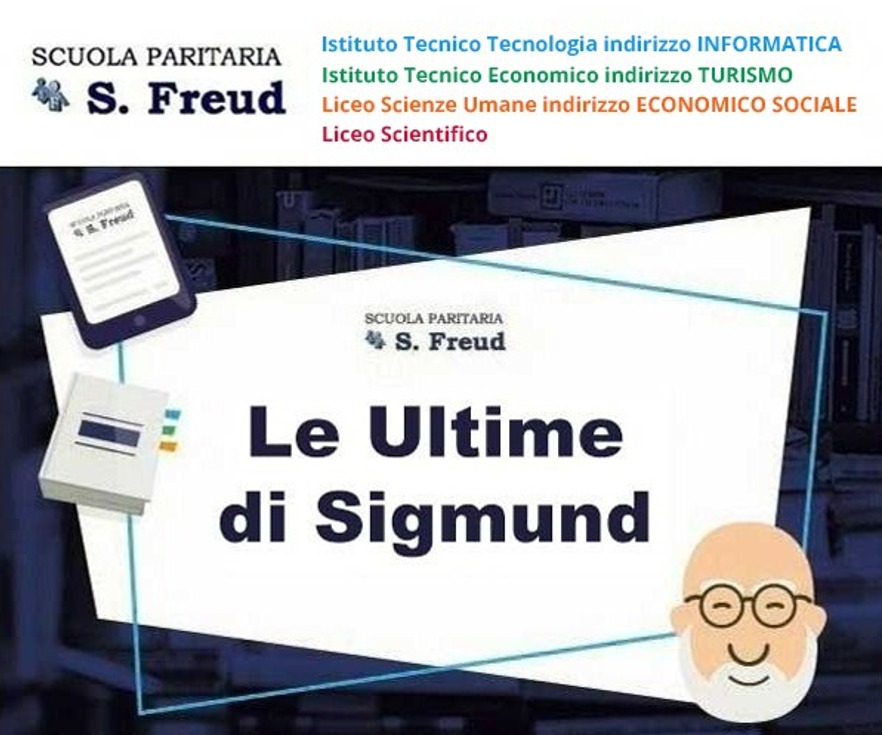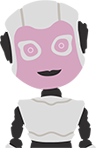21 marzo 2016
“Per non assuefarsi, non rassegnarsi, non arrendersi, ci vuole passione. Per vivere ci vuole passione”. Sono le parole, monumentali e granitiche, di Oriana Fallaci, una giornalista – forse la Giornalista per eccellenza – che con la sua passione a tutto tondo ha fatto del proprio lavoro una ragione di vita e della propria vita una continua scelta di devozione e abnegazione nel testimoniare fatti controversi e scomode verità.
Lavoro e passione. Due concetti che l'opinione comune colloca agli antipodi. Perché il lavoro sarebbe costrizione. Perché sarebbe il tempo libero lo “spazio” da dedicare alle proprie passioni. Un'equazione che ha le sue ragioni, perché no? Il lavoro non è stato e, per certi versi, non è ancora solo una questione di scelta personale: è stato sfruttamento, imposizione, scelta obbligata per far fronte a necessità contingenti. Ripeto: è stato e per alcuni (forse più persone di quante non si immagini) lo è ancora.
Si ipotizzi tuttavia una persona qualsiasi, in un giorno qualsiasi, sul proprio posto di lavoro, ancora, uno qualsiasi: che cosa cambia se quell'attività – quale che sia – viene svolta senza pensare alla busta paga, a quanto tempo manchi alla fine della giornata lavorativa, a tutt'altro che non sia quello che la persona sta facendo in quel momento?
Si accende la luce. Si passa dal bianco e nero al colore. Chiunque guardi dall'esterno e chi usufruisce dei risultati di quel lavoro vede qualcosa di completamente diverso. Non un lavoro, non un prodotto, non una merce (concretamente o metaforicamente parlando). Vede invece qualcosa che parla di colui che l'ha realizzata, con un suo timbro inconfondibile: l'anima e il cuore, un sigillo impresso, inalienabile.
E se può sembrare mera utopia – probabilmente lo è – pensare a ciascun individuo che compone il popolo dei lavoratori come un uomo intimamente coinvolto in ciò che fa, perché lo vuole, non perché deve, in certi settori professionali è invece assurdo (e pericoloso) anche solo ipotizzare che il lavoratore non sia il primo a credere in ciò che fa.
Medici e paramedici. Docenti di ogni ordine e grado. Educatori. Giornalisti. Magistrati. Militanti delle forze dell'ordine. Psicologi e psicoterapeuti. Cuochi. Ma quanto lungo potrebbe, anzi, dovrebbe essere questo elenco?
Certo, terrorizza pensare di essere curati da un medico che abbia scelto la sua professione per qualsiasi motivo che non sia la volontà di esercitarla con passione. Ma un accompagnatore turistico che ci conduca a visitare – per esempio – l'Acropoli di Atene, non ci piacerebbe che fosse entusiasta di ciò di cui ci parla? Perché altrimenti tanto varrebbe sfogliare le pagine di una guida in formato cartaceo o ascoltare la voce meccanica di un'audioguida. E un tecnico informatico cui diamo il nostro computer in riparazione, non vorremmo ugualmente che fosse appassionato del proprio mestiere, anziché essere un mero operaio di un'alienante catena di montaggio? Perché tali diventiamo, noi lavoratori tutti, indipendentemente dal settore e dal tipo di impiego, quando svolgiamo un'attività in modo meccanico, come fossimo automi. Quando non c'è dentro il calore di un cuore che si inebria della gratificazione morale per ciò che sta facendo.
Quale genitore iscriverebbe il proprio figlio in una scuola nella quale gli insegnanti sono diventati docenti perché pareva loro che l'insegnamento fosse un impiego tale da lasciare tanto tempo libero, che scaldano una sedia a una cattedra, che leggono senza partecipazione pagine e pagine di un libro senza mai alzare gli occhi sui loro allievi e senza mettere qualcosa di proprio nei contenuti, che contano i minuti all'intervallo, che assegnano compiti e voti senza un minimo di partecipazione emotiva? Domanda retorica. Perché nessuno lo farebbe.
Allora proprio i docenti, noi docenti, così spesso sul piede di guerra, perché scontenti delle riforme dei vari governi che si succedono, perché logorati da lunghe attese prima di giungere a una stabilità, proprio noi dobbiamo fare un passo indietro e chiederci: “perché sono un insegnante?”. Non conta averlo saputo quando la scelta fu fatta. Occorre saperlo ogni giorno. Perché all'inizio qualsiasi cosa è fonte di emozioni, per il semplice fatto di essere nuova: è facile sentir ardere dentro di sé il sacro fuoco dell'insegnamento a uno/due anni dalla laurea. Altro, ben altro, è sentirlo ancora con la stessa intensità quando il docente ormai inizia a contare le classi che ha avuto e che ha dovuto salutare al termine di un ciclo scolastico. Ed è facile appassionarsi a questo lavoro, q uando si ha l'attenzione dello studente perfetto (che poi, in fondo, non esiste): il ragazzo che non ha problemi in famiglia, che non ha alcun disagio emotivo, che prende sempre appunti e nella verifica li riporta parola per parola. Questo studente non ha bisogno di un docente, se non per vedersi attribuire voti iperbolici. Né il docente ha bisogno di lui, perché non è in una tale situazione che può riuscire a comprendere quanto sia votato alla professione che svolge. Ma certo, ben vengano gli studenti diligenti! Il paradosso, però, sta nel fatto che uno studente bravo sarà bravo con qualsiasi docente si trovi di fronte. Ma non è vero il contrario. Solo se il docente sarà un bravo docente con qualsiasi allievo gli capiti davanti, allora avrà messo alla prova il suo “sacro fuoco”. Sempre che sia suo interesse farlo. E quanto è auspicabile che lo sia?
Prof.ssa Daniela Ferro
Istituto Paritario S. Freud, Scuola privata a Milano per: indirizzo Tecnico Tecnologico Informatico e indirizzo Tecnico Economico Turismo Istituto Tecnico Informatico: una scelta vincente Istituto Tecnico Turismo: uno sguardo al futuro Scuola Paritaria S. Freud, la tua Scuola Privata a Milano Istituto Superiore Tecnico: Scegli e Diventa Perito INFORMATICO e TURISTICO 20131 Milano Via Accademia 26 www.istitutofreud.it