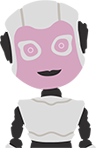2 settembre 2016
Nessuno sapeva nulla di lei, se non ciò che lei stessa diceva di essere, o che altri credevano lei fosse. La vera storia di Guglielmina detta “la Boema” è uno dei misteri più affascinanti che attraversa i secoli - non più bui dei successivi, in verità - del medioevo meneghino.
Nel Duecento una donna dava motivo di far parlare di sé, di lasciare traccia del proprio passaggio su questa terra in rarissimi casi eccezionali: nel bene, laica o religiosa che fosse, se apparteneva a una qualche dinastia di radici nobili e illustri, oppure se era una santa che si fregiava di qualche miracolo; nel male, se era una strega, un’eretica, una meretrice di Satana, insomma.
Caso più unico che raro, la nostra Guglielmina - chiamiamola così, giacché lo stesso nome con cui è passata alla storia potrebbe non essere veritiero, ma eredità anch’esso della leggenda - fu forse tutte tre. Forse, nessuna di loro.
Il suo è il destino di quanti non scrissero nulla, e conosciamo solo attraverso gli occhi (talvolta miopi) e la penna (spesso troppo parziale) di altri, che li ascoltarono, li videro, furono testimoni della loro parabola esistenziale, vedendo però in essa solo ciò che dovevano o volevano vedere.
Guglielmina è un personaggio pirandelliano, che vive di ciò di cui altri l’han fatta vivere: una donna che per noi oggi - quasi mille anni dopo - è quella che altri la credettero essere.
Doveva essere l’anno 1270, o giù di lì comunque, quando una giovane donna, di modi eleganti, squisiti, ma con quattro soldi in tasca e poco di più degli umili stracci che indossava, prese casa alla Bregonia, tra porta Orientale e porta Tosa. Aveva un figlio con sé, di pochi mesi a occhio e croce, ma non un marito. Non era milanese, non era neppure italiana, ammesso che tale aggettivo, allora, significasse qualcosa. Il modo in cui si esprimeva lo si capiva a stento, ma diceva che la donna non proveniva certamente da terre vicine.
Scoppiò subito il caso. La storia di Guglielmina conquistò la gente del rione. Una straniera non era cosa di tutti i giorni. Ci si chiedeva chi fosse, perché fosse giunta in Italia, chi fosse il padre del frugoletto e per quale motivo non fosse con lei. Sulla forestiera venuta dal nulla c’era una sola certezza: era povera, e presto non avrebbe avuto più nulla con cui mantenere sé e il bimbo. Eppure, le parole che con fatica la donna metteva insieme dipingevano un quadro da favola. Guglielmina diceva di essere una principessa, figlia nientemeno che di un mitico sovrano di Boemia, e di sua moglie, la regina Costanza. La sua educazione, la gentilezza e la compitezza dei modi, l’aspetto delicato e fragile rendevano credibile il suo strabiliante racconto. Ma era pur sempre una storia a metà, nella quale poco o nulla quadrava. Guglielmina raccontava dei suoi nobili natali, ma non del motivo che l’aveva indotta a lasciare la famiglia e la patria, per Milano poi. E ad ogni modo, sarà stata pure una principessa, ma aveva difficoltà persino a trovare il pane quotidiano. Perché?
Il racconto di Guglielmina non era poi così strampalato né era il delirio di una paranoica in preda ad allucinazioni. Nella seconda metà del tredicesimo secolo il regno di Boemia ebbe davvero una regina Costanza, figlia del re di Pannonia e moglie del mitico sovrano Premislao: lo attesta la genealogia dei sovrani di quel regno. Ma ciò che le fonti ufficiali non testimoniano è la presenza, nella dimora dell’augusta coppia, di una figlia di nome Guglielmina. Si parla di tre figlie femmine, in particolare di una tale Agnese, che prese il velo - come tante altre - sotto l’impeto di una vocazione forzata. Il che ha dato adito alle più ardite supposizioni: che Guglielmina e Agnese fossero la stessa persona? Che la figlia di Premislao fosse una Monaca di Monza in chiave boema? Che il bambino portato da Guglielmina fosse il figlio della colpa, e che la donna fuggì lontano dai confini del regno per sfuggire alla tremenda punizione che invece, forse, colpì il suo amato? Può essere.
I vicini di casa di Guglielmina, naturalmente, ignoravano la realtà di cui favoleggiava la straniera. La maggior parte di loro, probabilmente, non sapeva neppure che cosa e dove fosse la Boemia. Ma una cosa li trovava d’accordo con le successive supposizioni - e speculazioni - degli storici a venire: Guglielmina doveva averla combinata grossa per essersi ridotta nello stato in cui l’avevano conosciuta, e nulla di più probabile che di mezzo ci fosse un uomo, o comunque una storia d’amore finita male.
Comunque, le credettero. Alle chiacchiere e ai pettegolezzi si sostituì presto un’ammirazione sincera ed incondizionata. Perché Guglielmina era adorabile: si comportava davvero come una principessa, a dispetto di un’indigenza materiale che portava comunque con distinta dignità. E non poteva essere una millantatrice una donna che, nonostante le difficoltà quotidiane che l’affliggevano, dimostrava di possedere una nobiltà d’animo fuori dal comune: sempre una buona parola per tutti, sempre disposta a soccorrere chi se la passava male. Diventò l’amica più premurosa degli orfanelli senza un tetto, di vedove che sopravvivevano a stento, di malati e storpi che invocavano ogni giorno la morte come fine delle proprie sofferenze. Per loro Guglielmina si privava anche del poco che aveva. Trascorreva le ore al capezzale dei moribondi. Non si tirava indietro neppure davanti allo scempio con cui morbi allora ignoti devastavano il corpo dei poveri malcapitati. E la sua dedizione al prossimo non fu minacciata neppure dal grave lutto che l’afflisse, quando il suo bambino scomparve prematuramente. Ciò non le impedì, pur con la morte nel cuore, di andare ad asciugare le lacrime di chi soffriva mentre i suoi occhi ne erano colmi a loro volta. Per tutti non era più una straniera o la principessa decaduta: nel suo quartiere, si cominciò a vociferare che fosse un angelo sceso dal cielo.
Angelo, principessa, straniera che fosse, poco dopo la morte del figlio Guglielmina pensò di cambiare casa. Fece fagotto - e non impiegò molto, aveva davvero poco con sé, specie dopo la morte del figlio - e lasciò la Bregonia: era arrivata come una donna da cui diffidare; se ne andò in odore di santità popolare.
Troppo tardi. La fama di Guglielmina la precedette. Quando la Boema - così ribattezzata dai milanesi, giacché vantava origini in quella terra - si installò nella contrada di San Pietro all’Orto (esiste ancora oggi una via con lo stesso nome, proprio alle spalle del Duomo), la gente di lì accorse a frotte alla porta della sua nuova casa. La voce popolare aveva naturalmente ingigantito gli eventi: da donna caritatevole, che prestava soccorso e conforto agli afflitti, la figura di Guglielmina era stata distorta in quella di una guaritrice, di una sorta di santa taumaturga. E forse, se tale fosse rimasta per il popolo, per la plebaglia rozza e ignorante, sempre a caccia di qualche santerello con un effetto placebo per alleviare le sofferenze del volgo, la Chiesa di Roma non si sarebbe mai presa a cuore il caso di questa misteriosa donna venuta dall’Est. Ma non fu così.
Ambienti religiosi non rigorosamente ortodossi avevano sentito parlare di Guglielmina, e avevano nutrito un particolare interesse per la sua figura. In particolare, le suore Umiliate del monastero di Santa Caterina in Brera arrivarono a stabilire con la Boema un rapporto molto stretto, addirittura intimo. Come mai?
Il trait d’union tra le religiose e Guglielmina fu probabilmente lo stesso motivo che aveva portato la donna a Milano: un uomo. In questo caso specifico, si trattava di un benestante cittadino milanese, tale Andrea Saramita (forse un mercante), talmente affezionato e devoto all’ordine degli Umiliati da far dono al monastero in Brera di una sorella e di una figlia. Costui però era devoto anche ad un altro genere di donne: non disdegnava affatto la compagnia femminile, e non sembrò disdegnare quella di Guglielmina, di cui divenne amico intimo, tanto da insinuare in chi conosceva la Boema il sospetto che il Saramita fosse addirittura il suo amante. D’altronde, di una donna di cui non si sa nulla è possibile dire tutto, e il contrario di tutto: il mistero femminile è il motore della fantasia a ruota libera.
Fatto sta che tramite l’uomo, Guglielmina e le Umiliate di Santa Caterina in Brera stabilirono un primo, fruttuoso contatto, cui ne seguirono molti altri. La donna apprezzava la scelta pauperistica delle suore, le quali erano conquistate a loro volta dalla generosità e dall’abnegazione con cui la Boema si prodigava in cure ai più bisognosi. E il legame si protrasse anche quando Guglielmina decise bruscamente di interrompere ogni rapporto col Saramita. Costui, da semplice amico (più o meno innamorato), si era fatto profeta di un vero e proprio culto incentrato sulla figura di Guglielmina, della quale decantava non più solo la santità, ma perfino una natura divina, dal momento che - queste erano le voci diffuse dall’uomo - la Boema sarebbe stata addirittura l’incarnazione dello Spirito Santo, come Gesù Cristo lo era di Dio. E se la prima affermazione (la santità della donna) era già di per sé un motivo valido per generare nelle autorità ecclesiastiche un sospetto, la seconda (la presunta incarnazione) era molto di più: era eresia. Ce n’era di che andare a prendere a casa sua la donna, metterla ai ceppi e processarla davanti al tribunale del Sant’Uffizio, tanto più che ora non era più solo il popolo a venerarla come una santa, ma lo facevano anche delle religiose, delle suore, sottoposte all’autorità della Chiesa cattolica. L’equivoco - sempre che di questo si trattasse - doveva avere fine, e subito, prima di generare conseguenze pericolose e nefaste. Per tutti.
Guglielmina subì due volte le inchieste e il processo della Santa Inquisizione, un nome che a Milano era noto da poco. L’autorità del Tribunale era presente in città solo da pochi decenni: vi si era insediata ufficialmente nel 1218; tuttavia rimase scarsamente operativa fino alla fine del secolo successivo, quando la sua falce cominciò a mietere centinaia di vittime nella mattanza impietosa nota col nome sommario di “caccia alle streghe”. Quello di Guglielmina, se vogliamo, fu un po’ il battesimo del fuoco per l’Inquisizione milanese, che tuttavia in entrambi i procedimenti aperti a suo carico fece un buco nell’acqua. Era noto che Guglielmina con le dichiarazioni del Saramita non aveva nulla a che vedere, che anzi aveva rotto i rapporti con lui, che aveva rifiutato le affermazioni dell’uomo, respinte con indignazione: “Io non sono Dio - replicò -. Sum vilis foemina et vilis vermis”. Dunque Guglielmina non aveva mai detto, con la propria bocca, alcunché di compromettente circa una sua identificazione con lo Spirito Santo, e neppure, a ben vedere, aveva preteso per sé l’aureola della santità. Era questo un culto che si era generato spontanemante dalla gratitudine di coloro cui la donna aveva fatto del bene. Era insomma la gente a ritenerla una santa: e non ci voleva poi molto a guadagnarsi tale fama in un periodo in cui la miseria la faceva da padrona, mentre le istituzioni ecclesiastiche latitavano colpevolmente accanto ai poveretti. Al massimo a Guglielmina si poteva imputare un tentativo di “predicazione”, ma non c’erano estremi per formulare un’accusa di eresia. I discorsi della donna non erano deviati né devianti: parlava rettamente, in modo onesto, di cose giuste. Non c’era proselitismo, Guglielmina non era sacerdotessa di nessun culto proibito. La gente la chiamava “santa”, credeva al Saramita - ossia che la Boema fosse l’incarnazione, nelle forme di donna, dello Spirito Santo -, la soprannominò “Felix”. Ma nulla di tutto questo era colpa sua. Evidentemente l’Inquisizione doveva ancora farsi le ossa, affilare bene le sue lame: non avrebbe tardato ad apprendere come trasformare le dichiarazioni di un sospetto in confessioni vere e proprie. Con Guglielmina era ancora presto, ai giudici mancava la perizia, e la donna fu rispedita a casa.
Per due interi lustri Guglielmina perseverò nella sua cura ai bisognosi, senza essere imputabile di alcunché. Proseguì la collaborazione con le Umiliate, ma non solo: si avvicinarono a lei e alla sua spiritualità anche i monaci cistercensi dell’abbazia di Chiaravalle, a sud della città. E fu proprio l’abbazia a ospitare le spoglie mortali della “Felix” Guglielmina, quando la donna spirò improvvisamente. Era il 24 agosto 1281: giorno in cui la Chiesa ricorda San Bartolomeo. E giorno di guerra, ancora: quell’anno Milano viveva l’incubo della sfida a singolar tenzone tra i Visconti e i Torriani. Con l’ultimo fiato in corpo, la Boema chiese che il suo corpo trovasse rifugio nell’abbazia. Intorno a lei, supina sul letto di morte, vi erano i suoi amici più cari, e quanti - i tanti - avevano ricevuto da lei aiuto. A loro Guglielmina raccomandò ciò che non si era mai stancata di “predicare”: l’amore per il prossimo, la fratellanza. Una santa non sarebbe stata salutata con meno affetto e calore. Non si può dire però che Guglielmina se ne andò in silenzio: il corpo della donna fu condotto immediatamente al luogo della sua sepoltura, a Chiaravalle (secondo le sue volontà), sotto un cielo minaccioso, che prometteva a breve tuoni e goccioloni. La folla che aveva sostato al capezzale di Guglielmina accompagnò le sue spoglie fino al luogo dell’eterno riposo. A guidare il corteo funebre, vi era il marchese di Monferrato coi suoi uomini. Il sagrato dell’abbazia fu presto saturo, gremito in ogni briciola di spazio utile. Il corpo di Guglielmina fu deterso con una mistura di acqua e vino, quindi ricevette l’unzione col sacro crisma, sotto gli occhi dei “discepoli” accorsi e rimasti ad assistere alla cerimonia, anche quando le nuvole in cielo mantennero la loro promessa, scaricando sulla mesta adunanza litri di acqua e fragore di tuoni. Scuola Paritaria Milano
Se la Chiesa sperò che la fine dei giorni mortali di Guglielmina si fosse portata nella tomba anche la sua aura di santità, si sbagliava. Perché la dipartita della donna, anziché rinchiudere il suo ricordo nel dimenticatoio, lo rinvigorì. E se da viva Guglielmina era stata la santa del popolo, adesso la morte le conferiva quella distanza, quello spessore, quella aulicità che la innalzavano facilmente a idolo di un culto. Se prima Guglielmina era stata ammirata e amata, ora era invece venerata. La sua tomba prese a essere quotidianamente visitata da torme di veri e propri pellegrini, che si recavano a omaggiare le spoglie della Boema, a chiedere una grazia, un miracolo: venivano accesi ceri, si ponevano sul sepolcro della donna persino le ostie, perché il contatto - si credeva - le avrebbe consacrate e avrebbe conferito loro un vigore taumaturgico. Quanto sarebbe sopravvissuta una devozione già così mirata, focalizzata su un personaggio, ma pur sempre confusa nel mare magnun della Chiesa cattolica? Istituto Tecnico
Ad Andrea Saramita riuscì ciò che la ritrosia dell’amica Guglielmina gli aveva prima impedito: sistematizzare il culto sorto spontaneamente intorno alla persona della Boema e raccogliere i (numerosi) devoti organizzandoli in un ordine, i guglielmiti. Dei quali - ça va sans dire - si elesse “teologo”, rinnovando il suo cavallo di battaglia: Guglielmina era l’incarnazione dello Spirito Santo; Guglielmina sarebbe risorta col corpo (come Gesù Cristo) il giorno di Pentecoste; Guglielmina aveva indicato quale sua vicaria ed “erede” una suora umiliata, tale Maifreda Pirovano (che il Saramita vedeva come una sorta di “papessa”, la quale avrebbe dovuto prendere il posto del pontefice); le verità di Guglielmina sarebbero state raccolte in altri vangeli (naturalmente quattro), a firma dello stesso Saramita.
Tutto questo disegno potrebbe apparire ai limiti di un lucido delirio. Ma non era così. O se ammettiamo che di questo si trattava - della patologia mentale di un esaltato - allora i malati dovevano essere molti, giacché le file dei guglielmiti si arricchivano giornalmente di schiere di adepti invasati dalla figura di Guglielmina. Non si trattava di una setta, ma di una Chiesa, con un suo profeta, suoi sacerdoti, sue gerarchie, suoi testi sacri, suoi inni, un suo calendario liturgico che si articolava in tre grandi festività, ciascuna relativa a modo suo alla figura della Boema, per commemorare la memoria della santa: San Bartolomeo, Ognissanti, Pentecoste. Ma periodicamente la liturgia dei guglielmiti prevedeva, a immagine e somiglianza della Chiesa ufficiale, la messa. Le adunanze dei devoti non avevano un’unica sede, ma le cornici privilegiate erano i chiostri dell’abbazia di Chiaravalle (a pochi passi dal corpo della Boema, dunque) e del monastero delle Umiliate. Uno dei più ferventi fra coloro che amministravano il culto di Guglielmina incarnazione dello Spirito Santo era Jacopo da Ferno, già noto ai giudici della Santa Inquisizione per quello che era: un eretico. Costui, proprio perché il suo nome e il suo volto non erano nuovi, ma un marchio a fuoco che avrebbe potuto portarlo sul rogo, disdegnava i luoghi prediletti per le riunioni degli adepti, preferendo invece la segretezza di una capannina nel proprio orticello. D’altronde col passare del tempo i guglielmiti avevano attirato sempre di più l’attenzione della Chiesa, e diventò preferibile ritrovarsi e officiare i propri riti in silenzio, al riparo da occhi indiscreti. E proprio nella capannina di Jacopo la papessa Maifreda si consacrò tale, e annunciò la resurrezione della Boema. Era il giorno di Pasqua dell’anno 1299: la vigilia di un nuovo secolo, ma anche il canto del cigno dei guglielmiti, del Saramita, della papessa.
Quella specie di satira pasquale che la Pirovano celebrò nella capanna dell’eretico Jacopo tolse all’Inquisizione anche l’ultimo dubbio per procedere. Era troppo tempo che i devoti della Boema officiavano liberi e ribelli il loro culto, facendo il verso e irridendo la Chiesa. La quale si era limitata ad osservare, inquieta e preoccupata, senza intervenire, anche perché tra le file dei guglielmiti vi erano personaggi di grosso calibro, a cominciare dalla vicaria di Guglielmina, ossia la Pirovano, cugina nientemeno che di Matteo Visconti, signore di Milano. Ma ormai le pratiche di quella che era divenuta a tutti gli effetti (anche per dimensioni) una Chiesa parallela avevano passato il segno: sulle riunioni dei guglielmiti gravava anche il sospetto che fosse praticato ogni genere di oscenità sessuale. Maldicenza o verità? Poco importa, dal momento che la Chiesa vi credette e, con buona pace dei nomi illustri di molti fra i proseliti del Saramita e della Pirovano, dichiarò aperte le ostilità. La denuncia che diede ufficialmente il via ai procedimenti a carico dei guglielmiti fu firmata da un loro confratello, tale Corrado Coppa, il quale, stanco ormai del regime di vita imposto dall’ordine, vuotò il sacco proprio davanti a un forse non ignaro Matteo Visconti. Il quale, che fosse già a conoscenza o meno di quanto udì dalle labbra (prezzolate?) del Coppa, si vide spinto in un vicolo cieco. Forse fino ad allora aveva saputo e taciuto per non compromettere una sua congiunta e dunque la sua famiglia; quanto sostenuto dal Coppa (che riferì con dovizia di particolari le presunte orge rituali dei guglielmiti) lo costringeva però ormai a passare sopra alla parentela con la “papessa” e ad acconsentire affinché le autorità competenti - i giudici dell’Inquisizione - facessero chiarezza su quei guglielmiti. Istituto Turismo
Nel 1300 ebbe dunque inizio il processo a carico di tutti coloro che furono riconosciuti appartenere all’ordine dei guglielmiti. Non tutti però finirono nel calderone dei condannati, anzi. L’Inquisizione si dimostrò eccezionalmente clemente nei confronti dei fratelli “deviati”, che furono riconosciuti (e quindi rilasciati) per quelli che erano: gente sempliciotta, che si era fatta traviare dall’immagine di una donna - Guglielmina - che tanto aveva fatto per i poverelli. La sentenza capitale fu pronunciata solo contro coloro che si rifiutarono di abiurare e di ricongiungersi alla Chiesa cattolica, ossia i promotori dell’eresia stessa: Andrea Saramita, Maifreda Pirovano, e pochi altri insieme a loro, che purificarono la propria anima nella brace dei roghi allestiti nel dicembre dello stesso anno a Sant’Eustorgio (allora sede del Tribunale). Dagli atti del processo contro Maifreda in particolare (forse il più delicato, data l’altolocata parentela della donna), conosciamo i capi d’accusa mossi contro di lei: la donna avrebbe dispensato benedizioni, detto messa, somministrato l’eucarestia, preteso gli omaggi dovuti al papa. Ma non era possibile considerare del tutto rimossa l’eresia se non ne venivano estirpate le radici. Occorreva intervenire anche sul cuore totemico del culto professato dai guglielmiti: le spoglie della Boema. Per tutta Milano girava la voce secondo cui, anche dalla tomba, la “santa” dispensasse benefici e miracoli. E così furono riesumate le ceneri di Guglielmina, che pure lo stesso tribunale dell’Inquisizione aveva riconosciuto a suo tempo - e per due volte - innocente, ed arse sul rogo. Nella vicenda di Guglielmina, vissuta e morta da santa, poi condannata, già deceduta, come eretica vive in modo esemplare la dialettica che attraversa la complessa e multiforme spiritualità medievale, nella quale vi era solo una pira di legno a separare la santità dall’eresia.