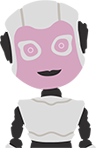24 giugno 2016
Benessere sul posto di lavoro, ciascuno ha il suo punto di vista, le opinioni cambiano di collega in collega, quando si passa alla percezione dell’ambiente da parte di dipendenti il quadro cambia ancora.
La compagnia Oxford Economics, per esempio, ha condotto un’indagine (When the walls come down) sulle categorie di lavoratori per scoprire, tra i vari aspetti, come si lavora in un ufficio open-space.
Le differenze sono in evidenza: solo il 35% dei dirigenti pensa che il rumore possa ridurre la soddisfazione e la produttività dei dipendenti, ma è il 53% dei dipendenti che ritiene di soffrirne le conseguenze. Il 63% dei dirigenti pensa che i propri dipendenti abbiano le capacità per filtrare le distrazioni sul lavoro, mentre solo il 41% è convinto di esserne in grado.
Pertanto niente open-space, tira su i muri come prima? Forse no, visto che stare a stretto contatto con i colleghi, sembra far sì che riusciamo a terminare i progetti fino al 32% più rapidamente rispetto a quando ci lavoriamo con qualcuno “a distanza”.
La vicinanza fisica significa comunicare di più anche per via digitale, dicono le indagini di Sociometric Solutions, al punto che gli scambi di email tra colleghi in questa situazione sono fino a quattro volte più frequenti (il che, effettivamente, potrebbe essere un deterrente per molti). D’altronde la privacy e la capacità di concentrarsi sono solo uno degli aspetti regolarmente nel mirino in un periodo storico in cui cambia il concetto stesso di lavoro, e con esso l’idea di come il luogo di lavoro dovrebbe essere e di quanto sia necessaria la nostra presenza in ufficio.
La diatriba principale è in continua evoluzione, con la bilancia che pende dal lato dell’elasticità – resta proprio quella tra lavoro in remoto a confronto con lavoro in ufficio, discussione che comincia ad arricchirsi di contributi scientifici interessanti e a volte inaspettati.
Come un’indagine di Kevin Rockmann e Michael Pratt, che allerta sui rischi di quello che potrebbero chiamare “ufficio deserto”, in altre parole di quanta resta del lavoro di squadra una volta che in loco rimane solo alcuni individui, magari scollegati tra loro nelle mansioni, e che dunque non trae benefici dalla reciproca presenza.
Tra le tecniche per migliorare il lavoro di squadra una in particolare è entrata a gamba tesa negli ultimi anni. Si tratta della mindfulness, vivere il “qui e ora” concentrandosi su quello che si sta facendo e basta. Un approccio (molto di moda) a lungo studiato mistico, spirituale e poco scientifico, ma che si sta lentamente arricchendo di evidenze in merito agli effetti positivi che comporta, anche sul lavoro. Negli uffici di Google, ma anche alla Mayo Clinic, è ampiamente sfruttata. Proprio per rimuovere la durevole patina di esoterismo, un gruppo di ricercatori ha elaborato un esame di oltre 4000 paper sui vari aspetti della mindfulness. Hanno terminato che riesce a migliorare tre specifiche elementi dell’attenzione – la solidità, il checkup e la validità – aiutando la mente a focalizzarsi sul presente e a lavorare meglio. I partecipanti agli studi che avevano compiuto un allenamento di mindfulness permanevano vigile più a lungo sia nei compiti di ascolto sia in quelli visivi. Pur trattandosi di una qualità individuale, scrivono gli autori dello studio, la mindfulness può migliorare le relazioni anche sul luogo di lavoro, incoraggiando maggior empatia in chi la pratica e ottimizzando quei processi che richiedono una direzione efficace ma anche un buon lavoro di squadra.
La questione è ancora più organizzata. “Sul posto del lavoro ci sono elementi concreti che possono modellare le funzioni cognitive: alcuni li puoi vedere, o toccare, altri no”, spiega Joseph Grzywacz, in uno studio sullo Journal of Occupational and Environmental Medicine. Nel flusso degli anni gli scienziati si sono interrogati più volte su quali fossero i fattori più svantaggiosi per il nostro cervello, se quelli materiali – come la sporcizia in ufficio – o quelli invisibili come una mancanza di stimoli e motivazione nei compiti. “Siamo riusciti a rivelare che ambedue computano nella salute cognitiva dell’adulto”, con ripercussioni sul benessere a lungo termine.
Basandosi sui dati di quasi 5000 adulti tra i 32 e gli 84 anni, Grzywacz e il suo gruppo hanno potuto documentare che chi sul lavoro ha modo di affrontare sfide, coordinare un ambiente complesso e migliorarsi, per esempio acquisendo nuove abilità, mantiene performance cognitive migliori via via che invecchia, specialmente le donne. A godere sono la memoria, ma anche la capacità di terminare i compiti in modo efficiente, di gestire il proprio tempo e di mantenere alta l’attenzione, applicando in un secondo momento le cose imparate. Secondo Grzywacz si tratta di un esempio solido, applicato al nostro cervello, del modo di dire “if you don’t use it, you lose it”, se non lo usi, lo perdi. Il secondo risultato ottenuto in quest’indagine riguarda un aspetto di quelli che si vedono a occhio nudo, in altre parole la sporcizia: sia uomini sia donne, quando il loro lavoro li espone a un ambiente sporco, vanno incontro a declino cognitivo.
Sulle conseguenze per la salute entro poco tempo, una parola che sentiamo sempre più spesso è burnout, esaurimento, crollo. Quello che succede quando lo stress lavorativo raggiunge il massimo e si arriva a un problema patologico. La Leeds Beckett University ha raccolto in un database tutti gli interventi più diffusi per prevenirlo e trattarlo (come workshop, occasioni di formazione, programmi cognitivo-comportamentali…) ed è arrivata alla conclusione che adoperarsi sull’ambiente di lavoro è più attivo e duraturo nei risultati rispetto al concentrarsi sulla singola persona. Nelle aziende solitamente avviene l’esatto contrario. Secondo i dati del Labour Force Survey nel Regno Unito, sul biennio 2013-2014, lo stress, l’ansia e la depressione legata al lavoro costituiscono il 39% dei casi di patologie che addolorano il lavoratore. Una percentuale che ha spinto i ricercatori ad attirare l’attenzione su cosa ancora non va sia dal punto di vista del trattamento sia da quello della prevenzione, fondamentale quanto spesso ignorata.
Gli interventi pensati per diminuire i sintomi e l’impatto del burnout, considerato una vera e propria sintomatologia che colpisce il lavoratore – nella sua individualità, nell’impegno sul lavoro e nelle emozioni che vi associa – sono condotti per la maggior parte sui singoli individui, su piccoli gruppi, trascurando il livello superiore. Che andrebbe preferito o, ancora migliore, integrato, trasformando il carico d’impegno e anche il flusso lavorativo, le pratiche da rispettare nel quotidiano. Abbinando i due approcci, scrivono gli autori nel rapporto, i risultati sono migliori e reggono più a lungo, perché aiutano a instillare un vero cambiamento nel sistema lavoro: l’ambiente diventa più partecipato, la comunicazione è più dischiusa ed è più facile degli impiegati siano coinvolti nelle decisioni e nella programmazione aziendale. “Ci sono prove scientifiche su cosa funziona e cosa no per trattare il burnout e lo stress legato al lavoro, ma sappiamo molto di meno riguardo a come prevenirlo, prima di tutto”, commenta James Woodall, della Leeds Beckett.
Affrontare anche quest’aspetto aiuta non solo la contentezza dell’individuo, ma la comunità. Come spiega Anne-Marie Bagnall, collega di Woodall e coinvolta nella stesura del rapporto, “è di grande importanza anche dal punto di vista della sanità pubblica e da quello delle aziende con l’obiettivo di moderare l’assenteismo e migliorare la produttività”. Il burnout non è solo l’esito di un processo di stress prolungato, ma è “associato a conseguenze negative per la salute come depressione, dolore muscolo-scheletrico, diabete di tipo 2, patologie cardiovascolari e mortalità prematura”, prosegue Bagnall. L’obiettivo finale dovrebbero essere luoghi di lavoro che concorrono a migliorare la salute fisica e mentale di chi li vive, e in questo modo divengono un valore aggiunto per l’azienda: una forza lavoro in salute si assenta di meno per malattia, ha bisogno di un cambio meno frequente e lavora meglio. “I dirigenti non possono permettersi di aspettare fino a quando l’esaurimento ormai è successo; è nel loro interesse mettere in campo interventi che possano prevenirne le cause principali, compreso lo stress e le condizioni che colpiscono muscoli e ossa”.